
La storia la conoscono un po’ tutti. New York, giugno 1965, studio di registrazione. Bob Dylan sta per incidere Like a Rolling Stone. Nessuno lo sa, ma il rock sta vivendo uno dei suoi giorni più leggendari.
Tra i musicisti presenti, seduto su un amplificatore, c’è anche Al Kooper, che però, data la presenza di Michael Bloomfield, non ha una chitarra in mano. Si mette dietro all’organo, suona qualche accordo mentre la band cerca un attacco che funzioni per il pezzo. Dylan lo sente e gli dice: “Bello, proviamo a registrarlo”. Kooper non è un organista (o almeno non lo era fino a quel giorno) ed è perplesso, ma naturalmente obbedisce. Ne viene fuori uno degli attacchi più riusciti della storia del rock, il primo mattone di una delle canzoni più importanti della storia della musica, in uno dei dischi più fondamentali della storia umana, fermatemi, vi prego, che da solo non ci riesco.
Quel pezzo, Dylan e i suoi, hanno provato a rifarlo molte volte. Non parlo delle migliaia di versioni live dal 1965 a oggi, ma proprio dei tentativi in sequenza per trovare la versione giusta da mettere su Highway 61 revisited. C’è un cofanetto meraviglioso, che si chiama The cutting edge, che contiene un intero cd di sole versioni di Like a rolling stone, tutte da quelle session, quindi fatte una dopo l’altra o giù di lì. E non ce n’è nemmeno una all’altezza di quella finita sul vinile.
Insomma, ci sono canzoni di Bob Dylan di cui esiste una versione senza rivali, che bussano alla perfezione, che vanno bene così. Il che è strano, parlando di Dylan, che raramente suona due volte una canzone nello stesso modo, e che non ha cominciato a trasformare i suoi brani, come crede qualcuno, con il passare dei decenni, per fare un dispetto ai suoi fan durante i concerti. Le ha cambiate fin da primo minuto, pensava ai cambiamenti da ventenne, mentre le suonava in un modo e le sentiva già in un altro. Ci sono pile di cofanetti delle bootleg series lì a dimostrarlo. Dylan ha cominciato con il folk, o almeno nel solco del folk, in cui in un certo senso le canzoni si riscrivevano ogni volta che qualcuno le suonava, aggiungendo parole, facendole sue.
Esistono versioni “definitive”, che fissano un canone per i pezzi di Dylan? In molti casi no, di solito no: ecco perché non bisogna rimanere delusi se dal palco arriva una Simple twist of fate che si riconosce alla seconda strofa, solo facendo attenzione al testo. Dylan è così: se lo cerchi in un posto, se n’è già andato. I’m not there, it ain’t me, babe. Eppure ci sono alcune eccezioni: performance rintracciabili tra quelle registrate e magari finite su disco che ci dicono che un pezzo difficilmente suonerà mai meglio di così. In occasione degli ottant’anni di Dylan, come scusa per scrivere un po’ di lui, ho deciso di metterne in fila una decina, e la prima ve l’ho già anticipata.
- Like a rolling stone (Highway 61 revisited, 1965)
Il colpo di rullante più incisivo che potrete mai ascoltare in vita vostra, l’apriti sesamo di una stagione, prima che Bruce Springsteen ne faccia un marchio di fabbrica. Quel colpo è il primo suono che si sente in quel disco, un istante dopo arrivano la chitarra (ovviamente) elettrica e appunto quel tappeto d’organo steso da Kooper. Ma non è un tappeto, è un rivestimento, sono arazzi che calano da cielo e avvolgono tutto. E sono poche note, di uno che non suona l’organo. Quando Dylan canta le prime parole, “Once upon a time” ormai il pezzo ha già rivoluzionato il rock and roll, ha già polverizzato le versioni che verranno, sue e di tutti quelli che ci proveranno.
2. Visions of Johanna (Blonde on blonde, 1966)
Qui siamo nel campo del soprannaturale. La versione contenuta in The cutting edge, con un tempo un po’ più frenetico e qualche strofa tagliata, è fantastica, e qualche anno fa Dylan ci fece montare un video altrettanto affascinante. Ma la versione che esplode, come la coscienza, dai solchi di Blonde on blonde, è una vera e propria epifania, è l’apice assoluto della produzione di un gigante. Con quella batteria che si aggiunge in punta di piedi, che rotola incerta per un paio di battute e poi costruisce il piedistallo del monumento più incredibile che Dylan abbia mai scolpito, sporgendosi a precipizio sulla libertà. And the visions of Johanna are now all that remain.
3. Love minus zero/no limit (The bootleg series Vol. 5, Rolling Thunder Revue, 2002)
La Rolling thunder revue del 1975, e il disco live che la racconta (e che per inciso è il mio album dal vivo preferito in assoluto) testimonia il Dylan forse più istrione di sempre, quello che prende canzoni scritte in una dozzina d’anni e decide di deformare la calligrafia con cui le ha composte, facendone la colonna sonora di un circo. Hard rain diventa una cosa ballonzolante, Tonight I’ll be staying here with you si fa beffe della (bella) versione patinata di Nashville Skyline, perfino Hattie Carroll si trasforma in qualcosa di completamente diverso dal giornalismo d’invettiva cantato nel 1964. Love minus zero/no limits invece rimane sintonizzata sulle frequenze di Bringing it all back home, ma mai come in questa manciata di minuti Dylan sfodera una voce crepata di imperfezione e allo stesso tempo assolutamente insuperabile, mai come qui si espone, mostrando una debolezza che lo rende invincibile. Di tutti i momenti di tutti i concerti che mi sono perso nella storia, se potessi, sceglierei di vivere questo.
4. Baby let me follow you down (The bootleg series n. 4, Live 1966, “The Royal Albert Hall” concert)
La famigerata svolta elettrica esiste, ma è anche un po’ una mezza bufala per come viene raccontata. A Newport pare che l’audio fosse inascoltabile, e se Pete Seeger ha mai pensato di tranciare i cavi con un’accetta, è perché non voleva che le parole di Bob Dylan fossero sepolte sotto quel frastuono. La vera svolta si legge benissimo in performance come questa del 1966, passata alla storia come il concerto della Royal Albert Hall, ma che in realtà viene da una serata a Manchester: Bob prende questo pezzo, non suo, che aveva inciso nel primo album e letteralmente lo mastica e lo risputa fuori fatto a pezzi, mangiandosi le parole, anticipando gli attacchi, strizzando i tempi, impadronendosi senza un briciolo di rispetto di una tradizione. O forse rispettandola come nessuno, mettendoci dentro se stesso.
5. Mississipi (The bootleg series vol. 8, Tell tale signs, 2008)
Love and theft è un disco che probabilmente ha lasciato a Dylan più di quanto si poteva pensare al momento dell’uscita, lontano sia temporalmente che per caratura dai capolavori più importanti (per comodità diciamo che fino a quel momento l’ultimo era Time out of mind e nessuno si offende?). Questo è un album con radici profonde, che infila le mani e le braccia nel blues, e non a caso la canzone migliore si intitola Mississipi. Per me però la versione più bella, che sembra suonata sotto il portico di una casa di legno, al caldo umido in mezzo alle zanzare e ai bambini che alzano la polvere correndo mentre una sedia a dondolo fa da metronomo (ho finito i luoghi comuni sul Delta, scusate), la versione più bella — dicevo — viene ripescata per l’ottavo volume delle bootleg series, e sfodera un Dylan degno dei capolavori, sì, anche di quelli veri.
6. Maggie’s farm live at Newport Folk Festival (The bootleg series vol. 7, New direction home: the soundtrack, 2005)
Ok, l’ho detto prima, la svolta elettrica è una storia po’ romanzata, ma mica inventata. Quando Dylan sale sul palco del festival folk più importante d’America, a Newport, i suoi fan si aspettano la chitarra acustica e una complicità da compagni di strada e di idee, invece lui tira su un muro di suono che lo separa dal pubblico, gli rovescia addosso questo diluvio di elettricità, questo fragore in cui sembra usare il rifiuto di fare lo schiavo nella fattoria di Maggie per rifiutarsi di riproporre il cliché che molti si aspettano da lui. Anche qui è un Dylan che mastica (in questo caso se stesso) e sputa, e facendolo, in effetti, un po’ di storia del rock la scrive, al di là di un racconto a posteriori che magari condensa una stagione in una serata.
7. Tangled up in blue (Blood on the tracks, 1975)
Se c’è un pezzo che Dylan ha spudoratamente deciso di scardinare nel corso dei decenni è questo. Lo suona spesso dal vivo, ormai da molto tempo, e anch’io che sono campione interregionale di riconoscimento canzoni ai concerti di Dylan, a volte ho fatto fatica. E ha cominciato a cambiarlo fin da subito, come è noto. Dopo aver registrato l’intero album a New York, anzi dopo che l’album era in procinto di essere stampato e distribuito, il nostro decise che quelle versioni non andavano bene, e lo registrò da capo. Questa canzone, che apre il disco, l’unico che regge il confronto (per molti uscendone anzi vincente) con le pietre miliari del biennio 65–66, spiega perché quella decisione era giusta. Anche se il disco di New York, pubblicato finalmente qualche anno fa come test pressing per un record store day, era bellissimo, anche se alcuni brani lì avevano il profilo esile della debolezza, anche se forse le parole cariche di dolore e rimpianto in teoria dovevano funzionare meglio con quel vestito più dimesso. Invece la canzone del disco, con quelle lame di chitarra e con Dylan che fa finta di infilare le dita nelle ferite di un altro e non nella propria carne, è così inarrivabile che forse è per questo che in seguito non ha mai provato a rifarla uguale, e anzi se n’è tenuto più lontano possibile.
8. One too many mornings (Inedita, Dylan-Cash sessions)
Diciamolo senza paura: le sessioni di registrazione del 1969 che misero insieme Dylan e Johnny Cash purtroppo non furono una somma di talenti, e non ci andarono nemmeno vicino. Se alla fine l’unico brano utilizzato fu la Girl from the north country finita in Nashville Skyline, un motivo ci sarà stato. Per quanto mi riguarda c’è almeno un’eccezione, ed è la versione di One too many mornings che si trova su YouTube, e che disgraziatamente non è nemmeno quella scelta per il volume 15 delle bootleg series, Travellin’ Thru, che dà testimonianza di quelle session. I due registrano praticamente dal vivo, si piazzano dietro ai microfoni con l’aria svagata, Dylan invece di masticare se stesso o la tradizione mastica un chewingum, Johhny Cash si prende le prime strofe e poi fa il gigione aggiungendo un “Bob” al testo, e l’altro gli risponde infilandoci un “I know it”. Non è un capolavoro, ma a dispetto della reputazione di entrambi, si sorride e si gioca.
9. You ain’t going nowhere (The bootleg series Vol. 11, The basement tapes complete, 2014)
Il clima non deve essere tanto diverso nel 1967 nella cantina della Big Pink, a Woodstock, dove il nostro si prende una pausa dal pubblico e si diverte a suonare un profluvio di canzoni, sue e di altri, insieme alla Band, padrona della grande casa rosa. L’album doppio uscirà nel 1975, per il cofanetto completo che invece restituisce almeno una parte dello splendore del padre di tutti i bootleg, quel Great white wonder che resta l’oggetto del desiderio di ogni dylaniato, bisogna aspettare nientemeno che gli anni dieci dei Duemila. Ma ne vale la pena, e non fate come me, che comprai la versione sintetica in due cd in una rara manifestazione di parsimonia, per poi arrendermi all’evidenza e portarmi a casa anche lo scatolone da sei.
10. Seven days (The bootleg series Vol. 1–3, Rare & unreleased 1961–1991, 1991)
Le note sul libretto che accompagna il cofanetto con i primi tre volumi delle bootleg series, quelli che probabilmente dovreste avere se un Dio malvagio vi obbligasse ad averne solo tre, raccontano che nel 1978, mentre Eric Clapton stava registrando un suo disco a Malibu, Bob Dylan era senza una meta precisa e gironzolava per gli studios (la leggenda vuole che avesse piazzato una tenda nel giardino). Un giorno fece ascoltare questo pezzo a Clapton, dicendogli “Se lo vuoi è tuo”. Il buon Eric la rifiutò, ma ci pensò Ron Wood, che era presente, a prenderla per inciderla nel suo Gimme some neck. Dylan l’ha suonata dal vivo cinque volte, nell’aprile del 1976, e poi mai più. Qui ho un po’ bluffato, perché questa, una delle cinque volte dal vivo, non è la miglior versione disponibile di questo pezzo: è l’unica pubblicata. E ora mi raccomando, al prossimo concerto, fatevi sotto e gridate “Seeeveeeeeen daaaaayyyyyys”, come fanno quelle povere anime che ancora chiedono Hurricane, quarantasei anni dopo l’ultima volta che l’ha suonata. Che tenerezza.
Ah, già, buon compleanno.




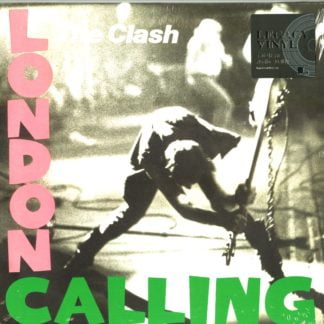


Bellissimo articolo, anche per neofiti