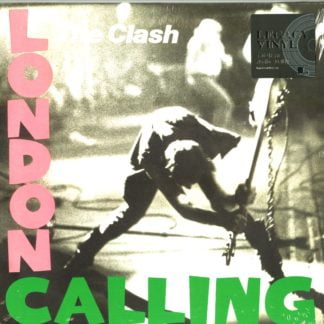I social hanno un grande vantaggio: fanno venire la curiosità – non a tutti forse, a qualcuno senz’altro sì – su cosa fanno alcuni artisti che ci piacciono. E’ stata proprio la curiosità su un lunghissimo tour che ha seguito uno degli album più interessanti del 2018 e che, per quelle strane alchimie temporali che a volte accadono con la musica, avevo riscoperto da poco, a farmi venire l’idea di un’intervista all’autore di quel disco, Paolo Saporiti.
Un’intervista come tante, domande che cercano di essere meno scontate possibile, ma che ti rendi conto, alla fine, sono sempre un po’ le stesse.
E, invece…
Invece è nata una chiacchierata che spaziava dal generale al particolare senza soluzione di continuità. Lunghissima, divertente e interessante. Ma praticamente impossibile da condensare per scritto. Come riuscirci? ‘Seguendo il flusso’, come dice Paolo. Già, perché, nel tentativo di dare una forma al tanto materiale, è nato uno scambio fitto, intenso, continuo… un flusso di idee e parole appunto, che, di fatto, ha portato a una stesura a 4 mani che ha disegnato una mappa fatta di colori, emozioni, sensazioni che traccia rotte per avvicinarsi a un mondo dalle mille sfaccettature. Il mondo di Paolo Saporiti.

Il 6 dicembre ‘Acini’ cambia veste e diventa un album dal vivo che ferma nel tempo e nello spazio i live che hanno portato Paolo Saporiti, questa volta in formazione a tre, ad esibirsi un po’ ovunque su e giù per lo Stivale. «Adesso stiamo assemblando tutto il materiale – spiega l’autore –, organizzando il teaser, la copertina, le foto, etc.». Insomma, siamo agli ultimi dettagli: «Sinceramente è venuto tutto molto bene – dice Saporiti –. Quando ho ascoltato le tracce, mi sono chiesto se fossi veramente io a suonare. Se fossimo veramente noi. Non ci potevo credere. Ed è stato proprio così invece e a questo serviva registrare. Per riappropriarmi di qualcosa che si è strutturato ed è cresciuto fuori di me. Insieme agli altri. L’idea di ‘fotografare’, deriva anche da questo: ‘fermare’ questa esperienza, indipendentemente da quanti lo ascolteranno poi, per potermi riappropriare di qualcosa di mio, ascoltare e comprenderlo, visto dall’esterno».
I live, dopo l’uscita di ‘Acini’ non sono certo mancati…
«No, devo ammettere che è andata molto bene, per tutto questo anno e mezzo di lavoro. Grande merito va ai musicisti coi quali ho collaborato, Alberto Turra e Lucio Sagone, che si sono prestati alla causa con entusiasmo e amore, come si trattasse di una cosa loro. Un riconoscimento enorme va all’affinità che si è creata e che c’è tra di noi. Grazie a loro siamo riusciti a reinterpretare al meglio, in una formazione scarna come quella del trio, la ricchezza degli arrangiamenti immaginati da Christian Alati, produttore artistico di Acini. Ne sono orgoglioso e la gente risponde sempre con maggiore entusiasmo. Non sembriamo mai quello che siamo in realtà, tre musicisti sul palco».

Come nasce l’idea di fare un tour in trio?
«Nasce dall’esigenza di poter portare in giro materiale più complesso e articolato, come quello appena dato alle stampe, a costi bassi e da una necessità umana/relazionale e di amicizia, sempre più preponderante. Nel tempo, una parte del percorso prevede una maturazione e una maggiore attenzione agli arrangiamenti, ai dettagli e ai suoni. Cosa che da solo non si può sviluppare più di tanto, nonostante si tratti del “mio modo” fin dalle origini. Ci ho provato con le macchine anni fa ma non si sostituiscono i musicisti o gli amici. L’interplay che mettiamo in atto, ogni volta, è impagabile. Amo suonare chitarra acustica e voce ma ci sono momenti in cui si ha bisogno che sul palco accada qualcosa di diverso e superiore a se stessi».
Cosa ti sei portato dietro dall’esperienza dei Todo Modo?
«Tanto ed è indubbio che grazie a quel progetto io sia riuscito a trovare un ulteriore centro per quello che faccio e per quello che mi interessa dire davvero. Il come, soprattutto. Ho dovuto spostarmi da me stesso, per poter entrare in un ruolo basato su altri aspetti e questo ha fatto sì che mi sia rafforzato nelle mie scelte primigenie, con nuove acquisizioni, attenzione per il particolare, ad esempio, per i gesti, per le parole stesse. Insomma, è stata comunque un’esperienza di apprendimento importante per me».

E, invece, cosa hai lasciato indietro volentieri di quell’esperienza?
«Quelle stesse cose, nel senso che nel mio piccolo ho sempre rincorso e ricercato la verità, svestire le maschere, a costo di risultare goffo ma non ne ho avuto paura, anzi ho sempre pensato che essere davvero se stessi sul palco fosse il punto di arrivo. Con Todo Modo ho dovuto provare a vestire i panni della rockstar che non sono e che non sarò mai probabilmente. Nessuno se non pochissimi lo sono stati davvero e poter tornare indietro, tornare a casa, è stato molto bello, alcuni non ce l’hanno fatta, per esempio (parlo di Cobain, Cornell, Weiland, Staley, etc… che hanno giocato ruoli ben più importanti del mio ma che hanno di sicuro pagato, a caro prezzo, il rischio corso). Rivestire i panni della normalità sul palco, se non per quello che si dice e si suona, è bello. È questione di equilibrio, almeno per me».
Dal tuo punto di vista, hai notato dei cambiamenti nell’atteggiamento del pubblico e nell’attenzione che viene data alla musica?
«Se parliamo degli ultimi anni, è evidente che tutto è cambiato, nel modo di fruire e di partecipare ma non è ancora chiusa la cosa. Non è risolta. Sono convinto che i cambiamenti siano ancora in essere e che ne vedremo ancora delle belle. Non credo che l’impoverimento a cui stiamo assistendo possa andare avanti ancora a lungo e quindi mi aspetto qualche reazione, per non parlare di una vera rivoluzione che ovviamente deve venire dai giovani… ma il fatto che la musica sia diventata sottofondo nei modi e nei contenuti, non può durare ancora a lungo, per chi la fa e men che meno per chi la ascolta».’
E’ la stessa cosa anche ai concerti o cambia qualcosa?
«Dal mio punto di vista, posso dire che qualcosa è già cambiato o sta cambiando, negli ultimissimi mesi. Non posso ancora tirare le somme del fenomeno ma qualcosa si è mosso. Ero abituato alla disattenzione. Non so dire se questo dipenda dalla bontà di quello che stiamo facendo noi – che magari convince maggiormente, rispetto a prima – oppure da un oggettivo cambiamento del pubblico, ma noto una maggiore partecipazione ai live. Paradossale rispetto a quanto detto prima, è vero, ma è così. La gente dopo i concerti ascolta, si emoziona, compra, riconosce e questo non è poco. Mi ero abituato molto male prima».

Ma come reagisce il mercato a un prodotto cantautoriale come il tuo?
«Non reagisce, di fatto. Non c’è mercato per un prodotto come il mio. È come se non esistessi all’atto pratico, a parte gli addetti ai lavori che mi hanno sempre concesso spazio e fiducia ma ormai sentir dire che sono rimasto ‘uno tra i più sottovalutati in Italia’ mi è quasi diventato indifferente. Siamo quasi entrati nella fase del “classico” ormai, senza aver mai raggiunto la notorietà. Un meccanismo alquanto particolare cui assistere da protagonista».
E questa ‘fase’, questo ‘meccanismo’ verso cosa ti portano? Cambia qualcosa rispetto al passato?
«No, mi porta semplicemente a credere ancora più nella bontà di quello che ho fatto, nella serietà delle mie scelte e a tendere verso un’unica e sola strada percorribile: convincere con la qualità. Punto a una lenta ascesa verso la bellezza e mi circondo soltanto di belle persone per poterla realizzare, esseri il meno collusi possibile con il sistema».
Come vedi tu quel movimento ‘indie’ che sta avendo così tanto successo in Italia in questo momento?
«Più di tanto non lo conosco, a essere sinceri, ma purtroppo credo che sia successo quello che temevo tanti anni fa. La maggioranza – le major – si sono spartite anche quella minima fetta di mercato che avanzava, prima contribuendo all’abbassamento del livello e poi sfruttandolo a piene mani, usando anche quelle figure di spicco che si sono piegate al mercato, pensando di poter entrare nel sistema per cambiarlo dall’interno. L’ennesima falsità o bugia che ci è stata raccontata».

Hai mai avuto l’idea o la tentazione di fare una canzone ‘da classifica’?
«Non credo di esserne capace, di averne gli strumenti. Bisogna avere un certo talento, molto preciso e non so se ce l’ho. Vero è che in America, con i numeri che hanno, anche un progetto come il mio può fare successo, senza snaturarsi tanto e questo ti sgrava dal dover scrivere pezzi “da classifica”, è una cosa che succede da sé a volte ma… In questo disco, a onor del vero, ero convinto che vi fossero abbastanza brani da poter essere mandati in radio ma non è successo nulla, tipo “La mia luna”, “Arrivederci Roma”, “Amica mia”. Ti dico solo però che nei live la gente ne canta i ritornelli e batte il piede al primo ascolto e di solito questi sono segnali precisi…»
In generale, quale musica ti piace ascoltare?
«Continuo ad ascoltare il passato a piene mani, dal jazz, alla musica classica, al folk: tutto quello che è contenuto in quello che faccio. Hip Hop sperimentale a volte, d’avanguardia, cerco di ascoltare le uscite interessanti: leggo molto per capire cosa si muove e un’ascoltata generale la do a quasi tutto. Alla fine, però, ricado sempre sulle mie cose, dove c’è la chitarra acustica e soprattutto dove c’è una bella voce: ne ho un bisogno atavico. Wilco, per esempio. Per quello che è il mio gusto, l’anima passa tramite la voce, quindi io sto bene lì. Dice che ce n’è. Poi se è anche vestita con le chitarre acustiche giuste, qualche rumore ogni tanto, qualche arrangiamento un po’ storto e strano, io inizio a sorridere e a stare bene. Ma anche questo oggi, si è un po’ perso. Rispetto a quanto dicevamo sull’indie, ad esempio, io non salverei una voce in particolare: riconosco e comprendo la ricerca ostentata di andare a trovare voci originali, però sono convinto che non una di queste rimarrà. Manuel Agnelli, nel suo modo di essere, è una voce che ha dettato un modo di cantare. Giovanni Lindo Ferretti ha un modo di cantare e scrivere nel quale si è identificata una generazione. Ci sono delle voci che i discografici dovrebbero prendersi la briga di coltivare, altrimenti accade che compaiono solo una serie di vocine tutte uguali e che si rispecchiano. Quando sono uscito con Rotten Flowers per la Universal, l’idea non era quella che facessi un mio percorso, ma che, in quel momento, potevano avere per le mani un Damien Rice italiano. Quello che a me verrebbe da dire è: ‘aiutami a far diventare quel Damien Rice italiano veramente, non a copiare pedissequamente quel Damien Rice’. Ma ‘l’aiutami’ è qualcosa che la casa discografica non prevede più. Non esiste più un discografico che ti prende per mano e che ti fa crescere. Siamo tutti abbandonati a noi stessi e, ogni tanto, qualcuno viene pescato perché sta già facendo qualcosa che serve a qualcun altro per merito suo. Questo succede perché la musica non fa fare abbastanza soldi e, quindi, non c’è margine per investire su qualcosa che succederà tra 15 anni. Il problema, però, è che a livello sociale sta venendo fuori l’esatto contrario e cioè che i pochi che stanno avendo risultati e che resistono e ce la fanno nonostante tutto, sono persone o società che hanno scommesso e tirato una linea dritta, etica, morale di comportamento e questa ha definito un’identità che è andata crescendo e si è affermata nel tempo. Minoranze che resistono e che ultimamente riescono quasi a fare rete…»

Ti sei fatto un’idea del perché accada questo?
«L’idea che mi sono fatto è che siamo tutti un poco più annoiati e stanchi di prima. I mercati si muovono su questo e lo sfruttano abilmente, abbassando sempre di più la soglia dell’attenzione. Si è abbassato il livello della consapevolezza e quello dello stupore, in genere. Il che è perfetto per riuscire a vendere ciarpame e convincere tutti della bontà di quello che si vuole, a seconda del momento, che tra l’atro dura sempre meno. In pochi rimangono in grado di emozionarsi, stupirsi e di muoversi verso, per incontrare e conoscere davvero tutto quello che è altro da sé. L’ignoto. A questo si aggiunge la paura e il deserto è servito.
Se non c’è stupore e c’è noia e non c’è nemmeno la capacità di sviluppare e provare empatia, nei confronti di quello che si vede o si incontra per capire, avviene la desertificazione dell’anima e dell’ambiente».
Non è un bel quadro…
«Non lo è ma d’altronde quasi nessuno di quelli che hanno scritto o fatto arte davvero, ha descritto un momento in cui il quadro fosse solamente positivo, covando nel proprio intimo la speranza di poter contribuire un giorno al cambiamento definitivo, ognuno impegnato nella sua piccola battaglia».
Per chiudere suggeriscici un film da vedere, un libro da leggere e un disco da ascoltare…
«L’ultimo Tarantino, ‘C’era una volta a Hollywood‘: non è un capolavoro assoluto ma parla di arte e di amore per il cinema e lo fa romanticamente. Parla della forza/speranza e convinzione dell’autore stesso che l’arte abbia la capacità di superare la realtà, con la sua forza, nel bene e nel male ma soprattutto nel bene. La storia è andata in un modo? Bene, io vi dimostro che col cinema posso stravolgerla e portarla fino a dove dico io, convincendo anche voi della mia nuova verità inventata. Una bomba. Quando esci ti domandi: ma la storia vera quale è? Che cosa voleva dirmi alla fine? Sono io che non conosco la storia o è lui che se l’è reinventata completamente e per dirmi cosa? In totale ti costringe a una vera e propria trasformazione del paradigma.
Come libro, ‘Essere una macchina’, di Mark O’Connell. Un testo sul transumanesimo. Una visione e una previsione, affrontata ironicamente, sull’avvento delle macchine da parte di un giornalista intelligente e sagace. La domanda alla fine è: siamo proprio sicuri che l’anima non sia tutto davvero, quella cosa che differenzia l’uomo dalla macchina e che non è riproducibile in alcun modo? Nonostante tutte le tecnologie del mondo. Nonostante tutte le ibernazioni di cervello, coscienza, corpo che possiamo immaginare di realizzare, con tutti i soldi a disposizione che possiamo avere nel mondo, L’uomo è e rimane anima. Il testo non lo dice ma lo dico io. Un libro che nell’opporsi al voler trattare il cervello e la conoscenza, l’essere umano, come sola informazione, ti costringe a non pensare ad altro per settimane.E, infine, Wilco “Ode to Joy” ovvero l’arte di dire tutto, facendo poco e niente ma con una classe clamorosa. Sembra di leggere Carver, tanto per dire ma non sto parlando dei testi che non ho ancora fatto in tempo a leggere, parlo della sensazione generale. La capacità di raccogliere l’assoluto nel particolare, raccontando il niente».